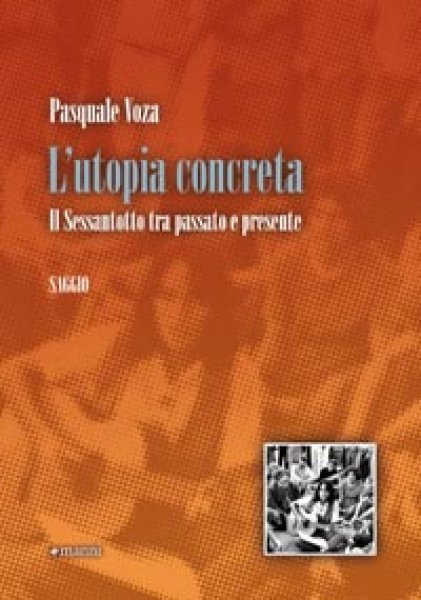L’utopia concreta
L’altro filone, in una sorta di sistemazione insieme apologetica e riduttiva, di storicismo sdrammatizzante, ha visto nel Sessantotto un fattore o un veicolo della modernizzazione in atto (nel campo delle istituzioni culturali e formative, del costume, dei rapporti familiari, del linguaggio ecc.). Vero è anche che quelle interpretazioni si sono andate via via come sfocando in una sopravvivenza confusa e remota, quasi che il loro oggetto fosse divenuto, piuttosto che strenuamente “inattuale”, semplicemente ingiallito e privo d’interesse. Ebbene questo ingiallimento e questa mancanza d’interesse, progressivamente emersi dalla fine degli anni Ottanta in poi, avrebbero dovuto essere interrogati e indagati – io credo – invece che essere accettati passivamente: ciò naturalmente da parte di chi avesse avuto bisogno di leggere – per usare una formula classica – il presente (il proprio presente) come storia.
D’altro canto, se si guarda all’oggi più stringente, e in particolare alla ricorrenza del quarantennale, si può constatare invece la presenza sempre più pervasiva di un peculiare, acuto, interesse revisionistico, di vario segno, nei confronti del problema del Sessantotto. Del resto, sul piano del senso comune (anche in riferimento alle coscienze giovanili) la cultura diffusa del revisionismo, più in generale, ha teso ad imporre un Novecento seccamente “liberato” della sua reale complessità storica e ridotto ad una sorta di bene culturale e spirituale di cui fruire in un consumo inerte e pacificato: un consumo riconducibile ad una nuova forma di “americanismo”, da intendersi come terreno esemplare di caduta secca di ogni rapporto critico col passato e col presente, e con le forme culturali e ideologiche dell’uno e dell’altro. In questo ambito, le aberrazioni anti-conoscitive e – direi – profondamente corruttive si sono andate ampiamente sprecando. Si pensi, ad esempio, alla nozione di totalitarismo, proposta come mistificante, generico e qualunquistico, canone di lettura del “secolo breve”, e alla pratica del conteggio, da rissa al Bar dello sport, dei morti di un totalitarismo rispetto ad un altro: esempio questo della degradazione populistico-plebiscitaria di una importante, ancorché discutibile, categoria di ordine etico-culturale e storiografico (quale quella, appunto, di totalitarismo).
Rovesciare il ’68 è il titolo di un recente volume di Marcello Veneziani, che si può assumere come emblematico di questo revisionismo selvaggio, spiccio e perentorio. In una prosetta vagamente aforistica e laboriosamente spiritosa, del tutto priva della vera, grande forza dell’ironia, l’Autore si adopera ad illustrare la sua tesi di fondo, secondo cui il Sessantotto non è stato un «evento», bensì «un virus con effetti ancora attivi»: uno, tra i principali, di questi effetti viene indicato in una sorta di «intolleranza permissiva». Citando e semplificando fino all’estremo Del Noce e Pasolini, l’Autore attribuisce al Sessantotto il ruolo di promotore del «passaggio della borghesia dal vecchio universo cristiano-famigliare e nazionale a una neoborghesia spregiudicata e sradicata, priva di valori e pudori, irridente alla morale».
C’è chi ha constatato che «la caricatura di un Sessantotto opera di figli di papà un po’ tonti e un po’ fanatici furoreggia ancora», e si è chiesto «perché – quarant’anni dopo! – sopravviva un tale bisogno di riscossa, un’ansia demolitoria, nei confronti di un movimento talmente lontano nel tempo». La risposta va cercata – credo – all’interno di quell’acuirsi recente del furor revisionistico di cui parlavo: è qui che si collocano innanzitutto i vari tentativi in corso di mettere mano alla Costituzione, e alla forma-Stato ad essa connessa, attraverso l’attacco diretto o indiretto al valore dell’antifascismo come storico valore fondativo; ed è qui che si collocano anche, in questa fase estremistica della lunga transizione italiana, i bisogni di liquidare, di mettere in caricatura, di rendere invisibile la critica “inaudita” capillarmente portata dal Sessantotto alla strutturazioni egemoniche della forma-capitale. In un certo senso, si tratta dell’esigenza diffusa, ora indistinta ora consapevole, di sancire, di fissare una formidabile rivincita dell’esistente come base di un processo definitivo, se pure ancora laborioso, di normalizzazione del caso italiano.
Tale acuto furor revisionistico assume ed esaspera l’idea di un’onda lunga e nefasta del Sessantotto nella storia italiana. D’altro canto, uno dei problemi più complessi legati al Sessantotto, alla sua radicalità pervasiva, è proprio quello della sua cosiddetta durata. Ora, per quanto concerne quello che viene indicato come il progressivo impazzimento estremistico-corporativo della società italiana, ivi compreso l’esito degli anni di piombo, ebbene si deve dire che non dal Sessantotto, bensì dalla sua morte, e insieme dalla formidabile “strategia della tensione” posta in essere (si pensi, in primis, alla strage di Piazza Fontana), si produsse quell’abnorme e violenta esasperazione dell’autonomia del politico, che caratterizzò il fenomeno della lotta armata e del “brigatismo”. L’“attacco al cuore dello Stato” era radicalmente fuori della ri-definizione della politica elaborata e perseguita dal Sessantotto, che gramscianamente riproponeva in forme inedite, nel tempo della modernizzazione neo-capitalistica, il problema integrale della egemonia, che non a caso poteva essere nominato anche come il problema della “irruzione della lotta politica nella vita quotidiana”. Dico gramscianamente, anche se invece il gramscismo italiano, vale a dire l’uso variamente storicistico della riflessione gramsciana, era stato oggetto, nel corso degli anni Sessanta, di un’ampia gamma di condanne e di rifiuti ideologico-politici e culturali a sinistra, da parte di riviste e di gruppi di segno “minoritario”.
Così pure, per quanto riguarda i processi di dequalificazione che sempre più investirono nei decenni successivi, in Italia, le istituzioni formative e culturali (scuola e Università), essi sono stati sempre visti in connessione con quello che è considerato uno dei frutti più pervasivi della stagione sessantottesca, vale a dire la progressiva scomparsa del valore del merito, del criterio, indicato come educativo e produttivo insieme, della meritocrazia: laddove, storicamente parlando, va tenuto presente che quei processi di dequalificazione furono invece, in notevole misura, il frutto di una vera e propria rivoluzione passiva che fu posta in essere dalle classi dirigenti in risposta alle domande e alle spinte “inaudite” del biennio ’68-’69, e che produsse, tra l’altro, i provvedimenti di liberalizzazione degli accessi universitari. Tale liberalizzazione, deprivata in partenza di una prospettiva di riforma profonda della organizzazione complessiva degli studi, degli assi culturali e formativi, di una volontà di iniziativa politica e sociale sul terreno dei rapporti tra scuola, società, lavoro, finì col produrre ben presto l’effetto di una autogestione, da parte delle masse studentesche, della propria dequalificazione. (Naturalmente non si trattò di un esito lineare e privo di contraddizioni, che anzi furono ben presenti e talvolta assai forti.)
A ben guardare, il famigerato egualitarismo, che segnò una svolta dirompente nella realtà sindacale italiana, si costituiva in verità come critica di fondo della logica della produzione in sé e della assolutezza “naturale” dei valori e dei ruoli gerarchico-professionali. Si potrebbe dire che, in un certo senso, l’egualitarismo, così inteso, fu la forma operaria dell’anti-autoritarismo proprio del movimento studentesco e che su questo terreno si realizzò il massimo di convergenza, politica, culturale, sociale, tra lotte studentesche e lotte operaie.
Del resto, come dirò più avanti nel primo capitolo, la critica dell’autoritarismo accademico non si riduceva ad una mera rivolta contro il potere dei “baroni”, ma tendeva a configurarsi come una critica radicale di una struttura di potere che si esercitava propriamente attraverso il valore della cosiddetta autonomia dell’Università, vale a dire attraverso la “neutralità” e la “separatezza” del sapere e della scienza, e delle istituzioni deputate al loro sviluppo e alla loro trasmissione.
2. Ancora più complesso – direi – è il problema della durata del Sessantotto, visto dal lato della modernizzazione italiana. Ora, non c’è dubbio che quel movimento espresse un formidabile potere di critica della modernizzazione in atto, dei suoi valori, dei suoi miti, delle sue ideologie: del modello di sviluppo, del “sistema”, in cui essa prendeva corpo e si significava. Si deve aggiungere che l’eccezionalità studentesco-operaia del ’68-’69 italiano fece durare più che altrove quella critica radicale. In ogni modo, come critica “inaudita” della forma-capitale e proposizione nuova del problema della costituzione politica dei soggetti dell’antagonismo e del conflitto all’interno della complessità dei processi di modernizzazione neo-capitalistica, il Sessantotto, anche prima della deriva e della chiusura nella logica “marxista-leninista” (ovvero, “emme-elle”) dei gruppi e dei gruppuscoli, che in gran parte finirono per involversi nella ricerca di una sempre più rigida “ortodossia” e in un politicismo per lo più astratto e ideologico, moriva ben presto, privo come fu di “sponde” politiche, realmente capaci di farsene interpreti in profondità: ciò a partire dal pur complesso «rapporto mai risolto e sempre problematico» (F. De Felice) con la tradizione e la prassi del comunismo italiano.
E tuttavia, ad onta del rapido esaurirsi della radicalità del suo paradigma fondativo, le domande e le spinte del Sessantotto agirono e durarono in qualche modo all’interno della lotta e dei processi politici e sociali lungo il corso degli anni Settanta, soprattutto nella prima stagione di quel decennio.
3. Ove si pensi all’oggi, si potrebbe dire che la durata del Sessantotto si ripropone ora, in alcune letture e riflessioni, in forme meno storicamente determinate, talvolta nelle forme, vagamente storicistiche, di una “vecchia talpa” destinata, per così dire, a scavare incisivamente nel corso del tempo. Nella Prefazione al suo recente libro ’68. L’anno che ritorna, Franco Piperno, riassumendo il senso di due suoi distinti bilanci, parla dell’«opera di scavo, nella vita morale e civile del nostro Paese, che il ’68 ha portato avanti nella lunga durata, a venti e a quarant’anni rispettivamente da quella data».
È interessante inoltre rilevare come, in un capitolo che ripropone una riflessione del 1988, l’autore individui nell’«onda anomala del decennio ’68-77» una grande forza abbattutasi su una «omogenea percezione del tempo» sino ad allora vigente, su un «mito del tempo, imperante nella società italiana del dopoguerra», fondato su una concezione unilineare del progresso e della storia: l’effetto dirompente di quell’onda anomala sarebbe consistito in una sorta di «insurrezione contro l’ordine del tempo», nel «privilegiamento del presente», nell’assunzione perentoria del punto di vista del «qui e ora». Ebbene, non c’è dubbio che il Sessantotto abbia prodotto una rottura profonda nel senso comune imperante, introducendo – io direi – la forza del sospetto, della critica dello stato di cose presente, fin dentro la vita molecolare del dominio e dei modi e delle articolazioni in cui esso si esercita nella riproduzione sociale complessiva. Non a caso, allora, veniva rilevato e sottolineato che in quel «sistema economico-politico altamente interdipendente, l’analisi di ogni processo specifico disumanizzante […] può condurre a una percezione strutturale adeguata del capitalismo»; sicché poi, nei bilanci successivi più attenti l’accento è stato posto decisamente sull’opera – che in quella stagione prese corpo – di «disvelamento delle forme nascoste di interiorizzazione del dominio».
Sarebbe opportuno porre attenzione, oltre che sugli elementi di continuità (come fa Piperno), anche sugli elementi di differenza tra i due eventi del Sessantotto e del Settantasette. Essi, a ben guardare, non rappresentano «la data iniziale e quella finale del lungo “maggio strisciante” italiano». La dimensione planetaria dell’uno e quella sostanzialmente nazionale dell’altro valgono, più di ogni altro elemento, a segnare la discontinuità tra i due momenti. Secondo Revelli, la stagione del Sessantotto, intesa sostanzialmente come «elaborazione politica di una nuova socialità», si andò consumando in una parabola dei movimenti, che registrò abbastanza rapidamente il passaggio dall’apertura di uno spazio nuovo della politica alla sua progressiva chiusura. La vicenda del ’77 è da considerarsi all’indomani e fuori di quella stagione: è una vicenda nella quale – secondo lo studioso – masse giovanili, nel tentare di agire ancora nella forma di movimento, non poterono farlo che esplicitamente contro la politica, nella varietà dei suoi livelli. Si potrebbe dire allora che, se il Sessantotto aveva scoperto e tentato la politicizzazione della vita quotidiana, cioè, in altre parole, la critica molecolare dell’egemonia, a ciò il Settantasette “sostituiva” la valorizzazione immediata, l’autogestione, del vissuto e dei bisogni ad esso inerenti (“Riprendiamoci la vita”: era lo slogan dichiaratamente alternativo, che sembrava non avere ancora bisogno di una critica politica del biopotere né di una nuova e complessa prospettiva di soggettivazione.)
4. Un altro tipo di lettura della durata del Sessantotto è quello che punta su una continuità tutta ideologica tra un presunto rifiuto antidialettico del potere e dell’autorità, espresso da quel movimento, e l’attuale «vocazione al liberismo», intesa come una sorta di «approdo coerente di una generazione cresciuta all’insegna dello slogan “vietato vietare”». E, sul piano più propriamente culturale, artistico e letterario, c’è chi ha ravvisato nell’“irrazionalismo” e nel carattere “antimoderno” del movimento del Sessantotto («movimento cosmopolita, transnazionale e quindi mondiale di resistenza all’egemonia dell’alta cultura modernista») il «messaggero culturale e politico del successivo passaggio al postmodernismo». Lo stesso Bifo, ovvero Franco Berardi, molto più recentemente ha affermato che la stagione del Sessantotto ha costituito «l’origine – non la causa, ma la condizione di possibilità – delle forme del potere che si sono dispiegate nella postmodernità» e che «l’antiautoritarismo libertario, anima profonda» di quella ribellione studentesca ha portato con sé la rivendicazione della «liberazione della dinamica produttiva dai vincoli statalisti», concludendo che ciò ha finito con l’aprire la strada al «dilagare del neoliberismo». Del resto, Bifo, protagonista – come è noto – del movimento del Settantasette, aveva già parlato, altrettanto decisamente, di quest’ultimo, in un corto circuito idealistico e metaforico, come di una sorta di inaugurazione dello “spirito del tempo”, cioè dello spirito degli incombenti anni Ottanta, gli anni della deregulation e del primo neoliberismo, gli anni che, a suo avviso, «capovolgono ma al tempo stesso continuano lo spirito dello s-regolamento che si venne formando nel corso di quella tempesta […] che chiamiamo Settantasette».
Per lo studioso statunitense Paul Berman la continuità ideale del Sessantotto, piuttosto che attraverso lo «spirito del tempo», è verificabile su base generazionale e attraverso il filtro di due «diverse esperienze utopiche» che i giovani avrebbero vissuto da allora ad oggi: la prima, l’esperienza di sinistra, sia pure variamente declinata; la seconda, l’esperienza liberale della maturità, soprattutto negli anni successivi al 1989. Quella «storia di creatività e ribellione», delineatasi alla fine degli anni Sessanta, conteneva in sé i germi di una grande storia di libertà, destinata a inverarsi, secondo Berman, nell’ethos liberale emerso come un prezioso punto di riferimento nel groviglio terribile degli eventi e dei rivolgimenti succedutisi dagli anni Novanta ad oggi.
Ora, a parte l’impianto metodologico assai discutibile di queste letture, tutte in varia guisa improntate (anche quelle, direi, di ordine generazionale) ad una storia delle idee intesa come partenogenesi, ciò che finisce col risultare pressoché assente è un’analisi dei processi storici, sia in rapporto alla vicenda del Sessantotto sia in rapporto alla complessità dei decenni successivi.
La peculiare «geografia mentale» del Sessantotto, per la quale la generazione che accedeva alla sfera politica in quegli anni tendeva a definire «la propria identità, e le proprie appartenenze, in termini di specie, di umanità più che di singola nazionalità», si colloca e si significa all’interno di una specifica complessità della fase di passaggio agli anni Settanta su scala internazionale: entro cui (come dirò più avanti) è possibile rilevare un dato centrale, costituito dal progressivo esaurimento della fase espansiva che aveva caratterizzato la società e gli stati nazionali nel ventennio precedente, e dall’emergere di una fase molto più travagliata e drammatica, contrassegnata in modo crescente dall’acuirsi di tensioni economiche e sociali, dall’intensità dei conflitti politici e dall’instabilità e precarietà delle relazioni internazionali. Era qui che, in forme generalizzate, si destabilizzava il rapporto, sino ad allora esistito, tra masse e politica; ed era qui che prendeva corpo quella che Donolo chiamò «la concomitanza di tutte le forme della lotta di classe e della conflittualità anticapitalistica: lotte operaie, lotte sociali, lotte anti-istituzionali». Era qui soprattutto che si sviluppava la “inedita” critica di massa dei processi e dei profili formativi e, più in generale, di quello che fu indicato come il nesso “scienza-capitale”.
Così pure, lungi da letture “idealistiche” della cosiddetta durata del Sessantotto, bisogna guardare poi ai processi di ristrutturazione capitalistica in senso oligarchico di poteri e saperi reali (si pensi alla diagnosi e ai progetti, a tal proposito, della Commissione Trilaterale), che, a partire all’incirca dalla metà degli anni Settanta, andarono svuotando di senso e di potere democratico, in forme e misure diverse, gli apparati e le istituzioni degli stati nazionali. Si potrebbe dire che sul terreno della “questione intellettuale” è possibile registrare presto la parabola dal no sessantottesco contro il “sapere di classe”, contro i suoi statuti di “autonomia” e “neutralità”, ad una sorta di autogoverno degli specialismi, cioè di nuova ricomposizione della forma del sapere entro i confini dello specialismo e delle competenze: ricomposizione attraverso cui presero corpo processi di ristrutturazione, senza riforma, delle istituzioni culturali e formative.
5. Oggi il valore epocale e periodizzante del Sessantotto è come rovesciato nella grande “rivoluzione passiva” in corso: se l’internazionalismo intrinseco delle domande del Sessantotto poneva con forza – come s’è detto – il problema inedito della rifondazione della politica e della costituzione politica dei soggetti dell’antagonismo e del conflitto, capaci di agire la critica molecolare dell’egemonia, sulla base di una ri-definizione nuova del nesso nazionale-internazionale, ebbene oggi noi ci troviamo di fronte alla destrutturazione progressiva e pervasiva della soggettività politica (in atto almeno dagli anni Ottanta) e ai mutamenti molecolarmente radicali della forma della politica (con i connessi fenomeni che Rodotà ha chiamato della tecno-politica o anche della iperdemocrazia, con un termine che è ricavato da La ribellione delle masse di Ortega y Gasset, e che vuole indicare il carattere tecnologico-plebiscitario della “democrazia” postmoderna).
Tali problemi si connettono, in forme sempre più acute e drammatiche, con i processi in corso di dilatazione a mercato globale del capitale, col suo potere di “astrazione reale”, capace di pervadere ogni forma di vita, sociale e individuale, e inoltre capace di dar luogo a esiti e a forme di immaterialità e artificialità, non solo nella sfera della produzione, ma anche in quella del consumo: ad una sempre più pervasiva “catastrofe del valore d’uso” e ad una dilatazione estrema di quella che Baudrillard chiama la società, o la realtà, del «simulacro».
Qui va tenuta presente la vera e propria rottura epistemologica del femminismo, in tema di soggettivazione: vale a dire, l’affermazione di un punto di vista radicalmente altro, che è quello pratico-simbolico del soggetto femminile, che combatte e decostruisce il dominio di una millenaria, durevole e insieme rinnovantesi, naturalizzazione e astrazione, e lo decostruisce e lo disvela come divieto a produrre “altre rappresentazioni” ovvero a mettere in discussione le forme storicamente determinate del pensiero (neutro-maschile), entro cui esso soggetto è stato di volta in volta (drammaticamente) incorporato e annullato. Il femminismo, maturato allora all’interno del Sessantotto, ma come «rottura politica» nei suoi confronti (Boccia), ha contribuito e contribuisce in maniera decisiva a istituire e a proporre il nesso uguaglianza-differenza come fondamento del divenire dei soggetti, sociali e politici.
Oggi, nel tempo della ristrutturazione oligarchica dei poteri e della proliferazione-disgregazione atomistica della società, nel tempo del conflitto che potremmo nominare come conflitto capitale-vita, si pone acutamente il problema di una nuova, inedita soggettivazione radicale o, se si vuole, bio-politica. Ci può soccorrere, in qualche modo, la valenza gnoseologica e politica della nozione gramsciana di molecolare, con cui l’autore dei Quaderni, nel cuore degli anni Trenta, chiamando in causa il nesso spontaneità-direzione consapevole, designava il carattere del processo di formazione del soggetto sociale e politico, basato sulla «comprensione critica di se stessi» e su una lotta “interiore” di «egemonie politiche», di direzioni e di spinte che – egli affermava – si contrastano tra loro prima sul piano dell’etica e poi su quello della politica.